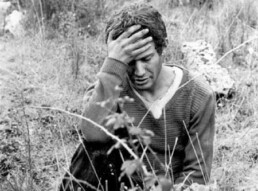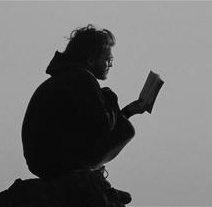Diritto dell'internet parte I: il marchio ed il nome a dominio.
[:it]Per riuscire ad entrare in questo argomento, si rende necessario esaminare in via propedeutica alcuni concetti che toccano sia il diritto industriale, che le regole consuetudinarie del mondo dell’internet.
Prima di tutto è necessario vedere come il nome a dominio viene inquadrato all’interno dell’ordinamento italiano. Il legislatore
ha disciplinato per la prima volta tale figura coll’art. 22 c.p.i. (codice della proprietà industriale), introducendo il divieto di adottare come “nome a dominio un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.
Il nome a dominio, pertanto, può anche rilevare come segno distintivo perché alla luce della progressiva “commercializzazione” della rete Internet l’imprenditore non si avvale più di un nome a dominio qualsiasi, ma richiede un determinato indirizzo Internet per rendere identificabili ai navigatori i prodotti o servizi offerti dal proprio sito commerciale.
La dottrina e giurisprudenza, anche anteriormente all’introduzione della suddetta definizione all’interno del c.p.i., ha riconosciuto la capacità distintiva del nome a dominio riconoscendo che: “non sembra fondatamente contestabile che il domain name nella specie assuma anche un carattere distintivo dell'utilizzatore del sito - atto a concorrere all'identificazione del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico a mezzo della interconnessione di reti (Internet) - con qualche apparente affinità con la figura dell'insegna, in quanto luogo (virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto”.[1]
Tale interpretazione viene nuovamente confermata anche a seguito dell’introduzione del suddetto art. 22 c.p.i. da una recente decisione del Tribunale di Milano del 20.2.2009 che conferma in via definitiva l’orientamento giurisprudenziale dominante favorevole al riconoscimento della natura distintiva del nome a dominio formatosi anteriormente al c.p.i.[2]
Alle norme sulla tutela dei marchi si affiancano anche le regole della rete. In internet vige, infatti il principio del “first come, first served”, in base al quale un nome a dominio viene assegnato al primo richiedente, indipendentemente dal fatto che sia in conflitto con altrui diritti di privativa. Gli enti preposti all’assegnazione dei domini non sono tenuti ad effettuare alcun controllo preventivo atto a prevenire/evitare la registrazione -quale domain name - di segni o marchi confondibili con un marchio registrato da parte di un soggetto diverso dal titolare del segno distintivo. In altri termini, in base all’attuale metodo di assegnazione dei domain names, tutti i nomi non ancora registrati (come domain name) sono liberamente registrabili da chiunque sulla base delle priorità delle richieste, indipendentemente dal fatto che tali nomi corrispondano o meno a denominazioni o segni distintivi di terzi più o meno noti.
A tal punto si rende necessario andare ad analizzare l’effettivo metodo applicativo delle suddette norme e, per far ciò, si rende necessario suddividere i marchi in due macrogruppi, ossia i marchi non rinomati e quelli rinomati.
a) casi di domani name di marchio non rinomato
Nel primo caso, qualora il domain name sia identico o simile a marchio altrui non rinomato occorre, perché questi possa inibire l’utilizzo del suddetto nome a dominio, la concorrenza di due requisiti:
- l’identità o somiglianza del marchio con il domain name (es. il marchio registrato è ABCD s.r.l. ed il terzo utilizza un nome a dominio coincidente www.abcd.it);
- l’identità o affinità dei prodotti o servizi offerti. (entrambi operano nello stessa branca del mercato);
In tal caso sarà applicabile il principio di specialità della tutela del marchio previsto e disciplinato dagli artt. 2569, comma 1. c.c.[3] e dall’art. 20 comma 1 c.p.i., lett. a) e b).
Ovviamente più i prodotti ed i servizi offerti sono vicini, tanto maggiore sarà la confusione del pubblico sulla effettiva provenienza degli stessi.
Pertanto, anche nel caso in cui non sussista alcuna identità tra i settori merceologici del marchio non rinomato e del domain name, qualora venga dimostrata la mala fede del titolare del nome a dominio, si ritiene tale attività essere idonea a precludere al titolare del marchio l’utilizzo in Internet come ulteriore segno distintivo e pertanto censurabile ex art. 22 c.p.i. [4]
b) casi di domani name di marchio rinomato
Nel caso di marchio notorio o di alta rinomanza, si ritiene indebito l’uso del domain name simile al marchio che anche nelle ipotesi di uso di segni per prodotti e servizi non affini se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.[5]
RIASSUMENDO
- il legislatore, ha disciplinato per la prima volta tale il nome a dominio coll’art. 22 c.p.i. (codice della proprietà industriale)
- l’orientamento giurisprudenziale dominante favorevole al riconoscimento della natura distintiva del nome a dominio
- nei casi di domain name di marchio non rinomato qualora il domain name sia identico o simile a marchio altrui occorrono, per inibire l’utilizzo del suddetto nome a dominio, che vi sia identità o somiglianza del marchio con il domain name e identità o affinità dei prodotti o servizi offerti
- nei casi di domain name di marchio rinomato, si ritiene indebito l’uso del domain name simile al marchio anche nelle ipotesi di uso di segni per prodotti e servizi non affini se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi
[1] Tribunale di Milano, ordinanza 10 giugno 1997 - Amadeus Marketing SA, Amadeus Marketing Italia s.r.l. c. Logica s.r.l.
[2] “Il domain name ha doppia natura, tecnica di indirizzo delle risorse logiche della rete Internet e distintiva. In quanto segno distintivo - costituito dalla parte caratterizzante il nome a dominio denominata Second Level Domain - può entrare in conflitto con altri segni in applicazione del principio dell’unitarietà dei segni distintivi statuito dall’art. 22 c.p.i.”. Tribunale Milano, 20.02.2009, Soc. Solatube Global Marketing Inc. e altro c. Soc. Solar Proiect e altro.
[3] art. 2569, comma 1. c.c.[3] “Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.
[4] Tribunale di Milano, ordinanza 10 giugno 1997 “La pratica confusoria illecita nota come domain grabbing consiste nella registrazione, presso la Naming Authority, del marchio altrui come nome a dominio, al solo fine di appropriarsi della notorietà del segno, costituisce in sé e per sé atto di contraffazione - censurabile ai sensi degli art. 22 c.p.i. - anche in quanto attività idonea a precludere al titolare dei marchio l’utilizzo in Internet come ulteriore segno distintivo”.
[5] Tribunale Milano, 20.02.2009 “La pratica confusoria illecita nota come domain grabbing consiste nella registrazione, presso la Naming Authority, del marchio altrui come nome a dominio, al solo fine di appropriarsi della notorietà del segno, costituisce in sé e per sé atto di contraffazione - censurabile ai sensi degli art. 22 c.p.i. - anche in quanto attività idonea a precludere al titolare dei marchio l’utilizzo in Internet come ulteriore segno distintivo”; Tribunale Modena, 18.10.2005 “L'assegnazione di un domain name (nome di sito web) corrispondente ad un marchio - anche solo di fatto, ma notorio - può costituire usurpazione del segno e concorrenza sleale in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio. Inoltre, la violazione di un marchio - perpetrata mercé il suo impiego quale domain name di un sito Internet - non è esclusa dalla circostanza che tale utilizzo sia avvenuto previa autorizzazione dell'apposita autorità preposta alla registrazione dei nomi di dominio, né dal fatto che il titolare del marchio non abbia in precedenza registrato presso detta autorità il medesimo nome”.
[:]
La contemplatio domini nei contratti stipulati dagli amministratori.
[:it]È principio consolidato in giurisprudenza e in dottrina che “…. anche nell'ipotesi di rappresentanza sociale è necessaria la contemplatio domini, onde, se il rappresentante di una società non ne spende il nome, il negozio dallo stesso concluso non spiega effetti nei confronti della società medesima
.”[1]
Dottrina e giurisprudenza concordemente affermano che il dettato normativo disciplinato dall’art. 1388 c.c. (“contratto concluso dal rappresentante”), sia applicabile analogicamente anche con riferimento alla rappresentanza organica, configurabile appunto in relazione ai soggetti che rivestono la qualifica di organi rappresentativi di persone giuridiche.[2]
Requisiti perché il contratto stipulato dal rappresentato possa produrre effetti sono essenzialmente tre:
1) il conferimento del potere rappresentativo;
2) l’agire del rappresentante nei limiti della procura;
3) la circostanza che al terzo sia resa palese dallo stesso rappresentante la riferibilità al rappresentato del regolamento negoziale (contemplatio domini);
É quindi necessario che tutti e tre gli elementi sussistano al momento della conclusione del contratto perché il negozio possa valere effettivamente nei confronti del rappresentato e se difetta anche uno di suddetti presupposti, il negozio produrrà effetti solo nei confronti del rappresentato.
Concentrandosi sul requisito fondamentale della contemplatio domini, si rende necessario evidenziare che tale elemento assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante e il rappresentato e di rendere conseguentemente possibile la imputazione degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo.
Secondo autorevole giurisprudenza, la spendita del nome del rappresentato nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam deve risultare in modo espresso non potendosi desumere esclusivamente da elementi presuntivi.
In tali contratti, il principio per cui tutti gli elementi essenziali del contratto devono risultare dal medesimo impone che anche la spendita del nome del rappresentato risulti ad substantiam dallo stesso documento in cui è contenuto il contratto.[3]
RIASSUMENDO
- anche nell'ipotesi di rappresentanza sociale è necessaria la contemplatio domini
- perché il contratto stipulato dal rappresentato possa produrre effetti è necessario il conferimento del potere rappresentativo, agire del rappresentante nei limiti della procura, la contemplatio domini
- nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam la contemplatio deve risultare in modo espresso non potendosi desumere esclusivamente da elementi presuntivi
[1] Cassazione civile, sez. II, 30/03/2000, n. 3903; si veda anche Cassazione civile, sez. lav., 25/10/1985, n. 5271 “se il rappresentante di una società di fatto non spende il nome dell'altro o degli altri soci, il negozio concluso spiega effetto solo nei confronti del rappresentante medesimo, ancorché esso riguardi interessi o beni comuni”;
[2] In tal senso, DE NOVA, Il contratto, vol. X del Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Utet, Torino, 2002, p. 10;SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, 1986 p. 288; in giurisprudenza per tutte Cass., 18 giugno 1987, n. 5371, in Giur. it., 1989, I, 1, 1056
[3] “Nei contratti conclusi dal rappresentante, [..] nel caso in cui sia mancata una espressa spendita del nome, in cui gli effetti del negozio si consolidano direttamente in capo al rappresentante anche se l'altro contraente abbia avuto comunque conoscenza del mandato o dell'interesse del mandante nella conclusione dell'affare [..], una eventuale contemplatio domini tacita non può essere desunta da elementi presuntivi”. (Cassazione civile, sez. II, 12/01/2007, n. 433)
[:]
Convegno sul contratto di agenzia in Biblioteca Civica.
[:it]Venerdì 8 giugno ore 15, presso la Biblioteca civica di Verona si è tenuto il convegno sul contratto di Agenzia che ho avuto il piacere di organizzare in collaborazione con Veronalegal. In qualità di relatori hanno partecipato l'avv. Valerio Sangiovanni (avvocato in Milano), la dott.ssa Maura Mancini (Magistrato del lavoro presso il Tribunale di Brescia), l'avv. Eve Tessera (avvocato francese, iscritta all'albo di Verona) e il sottoscritto.
Sono stati trattati i seguenti temi:
- studio di un contratto di agenzia (avv. Valerio Sangiovanni)
- l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (dott.ssa Maura Mancini)
- il contratto di Agenzia in Francia (avv. Eve Tessera)
- il contratto di Agenzia in Germania (il sottoscritto...)
Ringrazio sinceramente tutti i partecipanti al convengo e i relatori che si sono dimostrati essere, oltre che estremamente competenti, anche molto chiari e disponibili.
[:]
Art. 1451 c.c. Opponibilita' a terzi del negozio simulato.
[:it]Ai sensi dell’art. 1415 c.c. la simulazione “non può essere opposta dalle parti contraenti, dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente."In buona sostanza, la ratio è quella di tutelare il terzo rispetto alle parti, assegnando prevalenza all’affidamento che i terzi, in buona fede, hanno potuto porre sulla parvenza esteriore del contratto.
In merito la giurisprudenza si è pronunciata affermando che “perché la simulazione non possa essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall'accordo simulatorio.”[1]
La Giurisprudenza è concorde nell’affermare che il concetto di terzo di cui all’art. 1415 c.c. debba essere interpretato in maniera ampia e lata, dovendosi ritenere sufficiente che sussista una mera connessione o un semplice rapporto di dipendenza tra la situazione giuridica del terzo e l’accordo simulatorio.
Ad esempio si può leggere “….l'art. 1415 comma 1 c.c. dev'essere interpretato nel senso che la simulazione non può essere opposta dal titolare apparente ai terzi acquirenti in buona fede, ossia a coloro che, in base al contratto simulato, conseguono un effetto giuridico favorevole nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto….”[2]
Sul punto la stessa dottrina si è espressa in maniera del tutto concorde con il suddetto orientamento giurisprudenziale, affermando che per terzi ex art. 1415 c.c. si intendono tutti coloro che conseguono un effetto giuridico favorevole sulla base del contratto simulato (e ciò risponde alla regola generale secondo la quale chi crea una situazione negoziale apparente non può far valere a danno di terzi di buona fede la situazione reale.[3]
Del resto, altro non si tratta se non di una applicazione del più generale principio della tutela dell’affidamento “… Il principio dell'apparenza del diritto riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può invocarsi quando sussistano elementi oggettivi capaci di giustificare la convinzione del terzo in ordine alla corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale…”.[4]
Quanto poi alla buona fede del terzo, si osserva brevemente come dottrina[5] e giurisprudenza[6] sono concordi nel ritenere che il terzo sia dispensato dall’onere di doverla provare avendo questa natura presuntiva.
Infine, si rileva che in materia la mala fede si identifica non già con la “mera scienza” della simulazione, ma con l’intenzione di agevolare lo scopo in vista del quale è stata posta in essere la simulazione.[7]
Pertanto, il soggetto terzo non solo non ha l’onere di provare la propria buona fede, ma è compito del titolare apparente provare la sua mala fede.
- Ex art. 1415 c.c. il terzo è tutelato rispetto alle parti, avendo il legislatore dato prevalenza all’affidamento che il terzo, in buona fede, ha posto sulla parvenza esteriore del contratto
- Perché la simulazione non possa essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall’accordo simulatorio
- Il concetto di terzo di cui all’art. 1415 c.c. deve essere interpretato in maniera ampia e lata
- Il terzo è dispensato dall’onere di provare la propria buona fede avendo questa natura presuntiva, pertanto è compito del titolare apparente provare la sua mala fede
[3] cfr M. Bianca: Diritto Civile – Il Contratto – Giuffré pag. 667;
[5] Mengoni, Acquisto a non dominio, 1949, 117 e poi edizioni successive;
[6] Cass. 1949, n. 53; Cass. 1960, n. 1046; Cass. 1970, n. 349; Cass. 1987, n. 5143; Cass. 2002, n. 3102;
[7] Cass. 1986, n. 2004; Cass. 1991, n. 13260;
[:]
Onorari dell'avvocato e giurisdizione competente.
[:it]
Recentemente, con la sentenza del 12.10.2011 n. 2100, la Cassazione si è pronunciata affermando che “il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi)"va individuato, ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo
tempo”.[1]
Applicando tale principio all’attività professionale dell’Avvocato, risultano evidenti i risvolti pratici di suddetta sentenza. Come è noto, infatti, l’art. 20 c.p.c, che disciplina quale foro alternativo a quello generale del convenuto (art. 18 c.p.c). stabilisce che “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui [..] deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”.
Secondo la Cassazione, quindi, qualora non venga stabilito “ab origine” il compenso di un professionista, il credito non può definirsi liquido in quanto determinabile solo a prestazione eseguita. Pertanto a tale rapporto obbligatorio non è applicabile l’art. 1182 comma 3 c.c., che dispone che “l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.”
Data appunto la natura non liquida e determinabile del credito si deve invece applicare, secondo la Suprema Corte l’art. 1182 ultimo comma, che prevede, invece, l’adempimento dell’obbligazione al domicilio del debitore.
Tale principio è chiaramente applicabile anche alla professione dell’Avvocato. Infatti, il suo compenso la maggior parte delle volte non è determinabile a priori, soprattutto se riguarda un’attività giudiziale, non essendo possibile prevedere l’effettiva attività da svolgere nel corso del procedimento. Pertanto, secondo questo orientamento della Cassazione, qualora un Avvocato dovesse procedere per il recupero di un credito derivante da una proprià attività professionale dovrà agire presso il foro del convenuto ex art. 18 c.p.c. ovvero del debitore ex art 20 c.p.c.
RIASSUMENDO
- Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale
- Il foro facoltativo del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c.) va individuato, ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore
- L’Avvocato che vuole procedere per il recupero di un proprio credito dovrà agire o presso il foro del convenuto ex art. 18 c.p.c. ovvero del debitore ex art 20 c.p.c.
[:]
La giurisdizione in ambito di vendita internazionale di beni mobili.
[:it]
Spesso le parti, che stipulano un contratto internazionale di compravendita di beni mobili, omettono per svariati motivi di decidere e definire quale Giudice sia competente a decidere su una eventuale vertenza avente ad oggetto il contratto stesso.
In mancanza di tale scelta è necessario identificare i parametri dettati dal regolamento 44/2001. Lo stesso prevede che:
- è competente a decidere il Giudice dove il convenuto ha la sua residenza (art. 2,1);
- “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro” e nello specifico, nel caso della compravendita di beni, “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 5,1 lett. b).
Es. Una ditta italiana vende dei prodotti ad una ditta svedese. Le parti concordano che la merce deve essere consegnata a un concessionario con sede in Spagna. La ditta svedese consegana la merce in tempo, ma la società svedese non provvede ad adempiere.
La società svedese vuole agire in giudizio e si rivolge a un legale per avere delle delucidazioni in merito.
Ex .art 2,1 reg. 44/2001 in questo caso (in mancanza di scelta delle parti) la Giurisdizione competente è quella del convenuto, quindi la Giurisdizione Svedese.
Ad ogni modo, l’art. 5,1 lett. b) prevede quale foro speciale, in via alternativa, il Giudice del luogo in cui la merce è stata o avrebbe dovuto essere consegnata (Spagna).
Pertanto il venditore italiano (con sua grande sorpresa) non avrà diritto ad agire in Italia per chiedere il pagamento della propria merce.
Importante sottolineare che in base a un orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, tale principio è applicabile anche al caso in cui il venditore sia intenzionato a fare valere in giudizio il mero pagamento del corrispettivo.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “in tema di compravendita internazionale di beni, l'art. 5 n. 1 lett. b) del regolamento Ce n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, nei contratti di compravendita, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall'attore, ma l'obbligazione caratterizzante il contratto e, dunque, nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene; pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello della consegna del bene, che, se non stabilito nel contratto, andrà individuato con riferimento ai principi già affermati dalla Corte di giustizia Ce, determinando il luogo secondo le norme di conflitto del Giudice adito."[1]
RIASSUMENDO
in mancanza di scelta è competente a giudicare, anche sulle questioni vertenti sul pagamento del corrispettivo:
- il Giudice dove il convenuto ha residenza (art. 2. reg. 44/2001)
- il Giudice dove doveva essere consegnata la merce (art 5 reg. 44/2001)
- anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello della consegna del bene
[1] Cassazione civile 2009 n. 3059 Giust. civ. Mass. 2009, 3, 479
[:]
Scelta o non scelta della legge applicabile
Uno dei primi passi per la stesura di un contratto internazionale è la scelta della legge applicabile. Solo a seguito di tale valutazione si può infatti redigere correttamente un contratto, in quanto solo in questo modo le parti possono stendere un contratto sulla base dei dettati normativi del prescelto ordinamento giuridico.
Tale elemento, viene spesso “snobbato” o messo in secondo
piano dai non addetti ai lavori, ritenendo questi che tale scelta sia una semplice e mera formalità.
Solitamente, le parti che vogliono iniziare una collaborazione in ambito internazionale, inseriscono all’interno di un contratto quanto solitamente sono soliti inserire all’interno dei contratti nazionali, utilizzando talvolta dei contratti che hanno già utilizzato per regolamentare dei rapporti nazionali.
In realtà, una mancata scelta può portare a delle spiacevoli sorprese da parte di uno o più contraenti.
Caso 1
Per una più facile comprensione si ritiene necessario portare due esempi classici di problematiche collegate appunto ad una mancata scelta delle parti della legge applicabile.
Un preponente italiano stipula un contratto di agenzia con un promotore francese. Le parti non scelgono la legge applicabile, poiché ritengono sia del tutto superfluo. A seguito di un rapporto di lavoro di quattro anni, il preponente italiano stoppa la produzione. L’agente francese, pertanto, richiede una indennità di clientela pari a due anni di provvigioni, sulla base delle norme del diritto francese. In questo caso, in mancanza di scelta, si applica la legge dell’agente, quindi il diritto francese. Il preponente, a seguito con un colloquio con il proprio legale si avvede del fatto che secondo il diritto italiano l’indennità di fine rapporto è fortemente inferiore (ex art. 1751 c.c. "l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua...) .
Caso 2
Una società italiana stipula un contratto di fornitura merci con una società americana. Nel contratto nulla viene precisato in merito alla legge applicabile. Si stipula, inoltre, una clausola penale che obbliga il venditore americano a pagare una penale di € 10.000,00 in caso di ritardo nella consegna della merce. La merce viene spedita con oltre un mese di ritardo e nonostante questo la società americana non vuole adempiere al pagamento della penale. La società si rivolge da un Avvocato al fine di chiedere dei chiarimenti sui metodi coercitivi del pagamento. A sorpresa del cliente l’Avvocato gli spiega che la situazione varia fortemente in base alla legge applicabile. Infatti, la clausola penale risulta valida, salvo che il giudice non ne riduca l’ammontare qualora risulti manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.). Contrariamente la legislazione americana non prevede la possibilità di pattuire penali (penality), ma solo forme di fissazione forfettaria del danno (liquidated damages).
Uno dei primi passi per la stesura di un contratto internazionale è la scelta della legge applicabile. Solo a seguito di tale valutazione si può infatti redigere correttamente un contratto, in quanto solo in questo modo le parti possono stendere un contratto sulla base dei dettati normativi del prescelto ordinamento giuridico.
Tale elemento, viene spesso “snobbato” o messo in secondo
piano dai non addetti ai lavori, ritenendo questi che tale scelta sia una semplice e mera formalità.
Solitamente, le parti che vogliono iniziare una collaborazione in ambito internazionale, inseriscono all’interno di un contratto quanto solitamente sono soliti inserire all’interno dei contratti nazionali, utilizzando talvolta dei contratti che hanno già utilizzato per regolamentare dei rapporti nazionali.
In realtà, una mancata scelta può portare a delle spiacevoli sorprese da parte di uno o più contraenti.
La natura giuridica dello studio associato in Italia.
[:it]
E' ormai noto che gli studi legali associati sono, di fatto, privi di una propria personalità giuridica, rientrando, secondo la giurisprudenza “all’interno di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici,muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. e segg.”[1]
In ambito fallimentare, tale caratteristica risulta essere fortemente rilevante. Infatti, secondo un costante orientamento della Corte di Cassazione gli studi associati, essendo muniti di legale rappresentanza, non vantano alcun privilegio quando si tratta di ammissione al passivo fallimentare. Per la Cassazione, lo studio non è, infatti, assimilabile al soggetto individuale favorito dall'art. 2751 bis n. 2., essendo tale diritto insuscettibile di estensione analogica.
Una possibile soluzione a tale problematica, sarebbe quella della cessione del credito sorto per la prestazione svolta personalmente dal singolo avvocato allo studio legale. Tale condizione, ad ogni modo deve essere comunque allegata e dimostrata, non essendo, in astratto, considerabile quale effetto legale o naturale della partecipazione dell’avvocato allo studio, autonomo centro di interessi.[2]
RIASSUMENDO
pertano lo studio associato italiano:
- è un fenomeno di aggregazione di interessi sprovvisto di personalità giuridica, ma munito di legale rappresentanza;
- in ambito fallimentare non vanta del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2
- è comunque configurabile una cessione del credito sorto per la prestazione svolta personalmente dal singolo avvocato
[:]
Il regolamento Roma I e la legge applicabile.
[:it]
Qualora le parti non individuano la legge a cui il rapporto contrattale è sottoposto, si applicano i criteri di collegamento previsti dall’art. 4 del Regolamento Roma I (593/2008)
Nello specifico l’art. 4,1 individua inequivocabilmente quale legge bisogna applicare ad una serie di contratti, qualora le parti non abbiamo posto in essere la scelta (vendita, prestazione di servizi, franchising, distribuzione). Si legge, infatti che:
-
il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
-
il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
-
il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;
-
in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
-
il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;
-
il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;
L’art. 4.2 del regolamento, inoltre, prevede che qualora il contratto non rientri tra le categorie di cui all’art. 4,1 lo stesso è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale;
L’art. 4.3, infine, prevede che nel caso che nessuno di questi criteri consenta di determinare la legge applicabile, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.
RIASSUMENDO
In caso di mancata scelta verificare:
- se il contratto rientra tra le categorie disciplinate dall’art. 4,1 del Regolamento Roma I
- in caso contrario, si applica la legge nel quale la parte deve effettuare la prestazione caratteristica
- infine se nessuno dei suddetti criteri permetta la determinazione della legge applicabile, il contratto è legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto
[:]
La giurisdizione in base al Reg. 44/2001 CE.
[:it]
Un problema che spesso è collegato ai contratti stipulati da parti con residenza o sede in stati differenti, riguarda la scelta della giurisdizione, ovvero capire quale giudice è chiamato a pronunciarsi qualora le parti non abbiano esplicitamente operato tale scelta.
Nelle questioni relative a problematiche civili e commerciali tra un soggetto italiano e uno straniero bisogna in primo luogo
distinguere, i rapporti con controparti dell’area europea e controparti di paesi non facenti parte a tale area.
- Nel primo caso, si applicherà la normativa europea disciplinata dal Regolamento 44/2001 (Convenzione di Lugano)
- Nel secondo caso, invece si applicherà il regime generale di cui alla legge n. 218/1995 sul diritto internazionale privato, sempre che la materia non sia direttamente regolata da convenzioni bilaterali dei paesi in oggetto.
Analizzando brevemente la disciplina generale prevista dal regolamento europeo, si rileva che viene prevista all’art. 2,1 la regola generale della competenza del giudice del convenuto.
Sulla base di questo principio, dunque, in mancanza di scelta, se una delle parti è domiciliata presso uno Stato dell’UE, essa deve essere convenuta presso il Giudice di quello stato.
(es. attore Italiano, convenuto Spagnolo, ma con domicilio in Belgio, il Giudice contraente è quello Belga)
Tuttavia, il regolamento 44/2001 prevede agli art. 5, 6 e 22 delle deroghe a tali principio generale ovvero:
- gli artt. 5 e 6 reg. consentono in una serie di casi di convenire in giudizio un soggetto davanti a giudici diversi da quelli del domicilio;
- sono previsti all’art. 22 una serie di fori esclusivi, ossia inderogabili, indipendentemente dal domicilio della parte convenuta quali ad esempio i diritti reali immobiliari, validità, nullità e scioglimento di società, registrazione e validità di brevetti, machi disegni;
- le parti hanno comunque la facoltà di scegliere un foro esclusivo per mezzo di una clausola con cui viene prorogata la giurisdizione (art. 23).
RIASSUMENDO
In mancanza di scelta e qualora i rapporti siano tra controparti dell’area giurisdizionale europea, i Tribunali di quale Stato sono chiamati a decidere di una vertenza?
- Necessario guardare il reg. 44/2001
- L art. 2,1 del reg. 44/2001 disciplina il principio generale della competenza del giudice del convenuto
- Gli artt. 5 e 6 reg. consentono in una serie di casi di convenire in giudizio un soggetto davanti a giudici diversi da quelli del domicilio
- L’art. 22 dispone una serie di fori esclusivi, ossia inderogabili, indipendentemente dal domicilio della parte convenuta
[:]